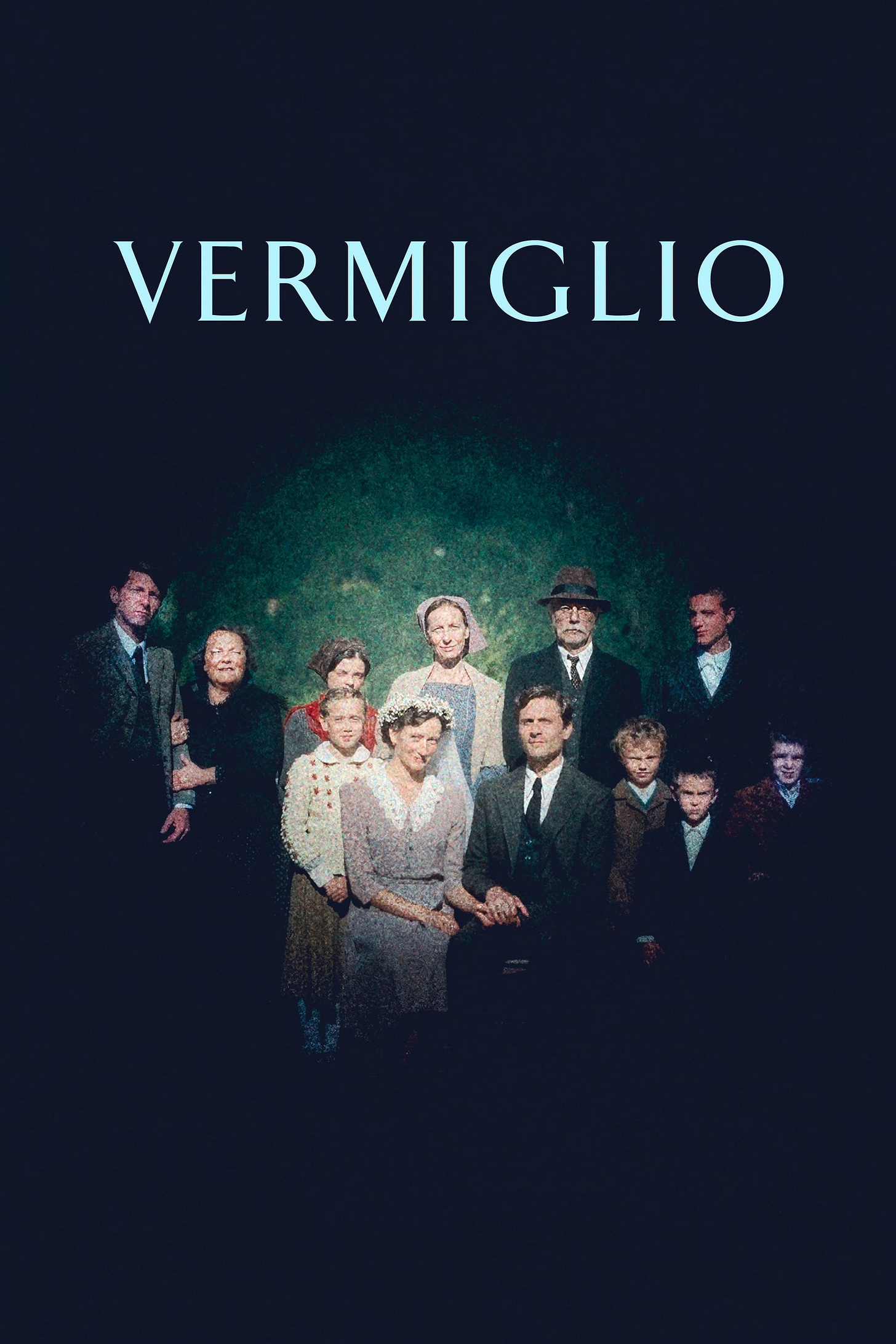Negli ultimi giorni ho visto tre film, molto diversi fra loro, in cui la maternità, o la genitorialità, aveva un ruolo centrale. Ho anche riguardato la lista di libri che ho letto quest’anno, come faccio ogni anno da qualche tempo per riflettere su quali sono stati i filoni più evidenti, e diversi avevano a che fare con questo tema. (Ognuno resti ai propri posti, non ci sono novità.) Questa sorta di coincidenza mi ha fatto anche ripensare a una cosa che è emersa mentre riflettevo sull’anno passato tramite le domande di Slavina: nel 2024 avrei avuto bisogno di più “mamma e papà”, espressione con la quale intendo, in questo caso, essere circondata di cose calde e profumate senza essermele dovuta procurare io. (Invito: di cosa avreste avuto bisogno, nel 2024, che non c’era?) In questo anno così frenetico, dove sono stata tanto spesso all’erta, attivata, ho praticato pochissimo lavoro di cura nei miei confronti. Dico questo senza negare l’infinita importanza della cura che ho ricevuto da chi mi ama (persone vicine e non), e anzi riconoscendo che parte di questa cura è stata anche materiale (una volta Federica mi ha lavato a terra, per dire), e che in buona parte è condivisa con Tommaso che per la maggior parte del tempo vive con me. Ciò nonostante, evidentemente non è la stessa cosa che tornare a casa e trovare la cena non solo preparata ma anche “pensata” nella sua “nutriziosità” e procurata materialmente da un’altra persona, o uscire una mattina di dicembre per rientrare in una casa trovando renne e lucine in giro, invece di disporle da me.
Quest’anno ho letto Cent’anni di solitudine: al liceo era stata una delle poche letture che ci aveva assegnato la Siciliano che avevo letto svogliata, e avevo ovviamente torto perché è un capolavoro totale. Miriam ha organizzato un gruppo di lettura, per cui abbiamo un po’ discusso di cosa voglia dire la solitudine del titolo: non vedo l’ora d riunirci una seconda volta per ritornare sul tema, e la ragione per cui lo menziono qui è che il personaggio forse più solo è Santa Sofia de la Piedad, che passa la vita a tenere in ordine la casa, prima assieme ad Ursula e poi da sola. Alcuni membri della famiglia pensano sia una serva, svuotando la sua cura della componente affettiva e relegandola ad un servizio professionale. L’ultima scena in cui la vediamo è una resa: la casa è troppo infestata perché il suo vecchio corpo possa tenerla a bada.
Senza né tempo né mezzi per impedire la prepotenza della natura, Santa Sofia de la Piedad passava le giornate nelle stanze a scacciare le lucertole che sarebbero ritornate di notte. Una mattina vide che le formiche rosse uscivano dalle fondamenti scalzate, attraversavano il giardino, salivano sul parapetto dove le begonie avevano preso un colore terroso, ed entravano fino in fondo alla casa. Cercò dapprima di ucciderle con una scopa, poi con l’insetticida, e per ultimo con la calce, ma il giorno dopo erano ancora nello stesso luogo, sempre in moto, tenaci e invincibili. Fernanda, nello scrivere lettere ai suoi figli, non si rendeva conto dell’aggressione inarrestabile della distruzione. Santa Sofia de la Piedad continuò a lottare da sola, combattendo contro l’erbaccia perché non invadesse la cucina, strappando dai muri bioccoli di ragnatele che si riproducevano in poche ore, raspando il tarlo. Ma quando vide che anche la stanza di Melquiades era ragnatelata e polverosa, anche se la scopava e spolverava tre volte al giorno, e che nonostante la sua furia sbrattatrice era minacciata dalla rovina e dall’aspetto di miseria che soltanto il colonnello Aureliano Buendìa e il giovane militare avevano previsto, capì d’essere sconfitta. Allora indossò il consueto abito della domenica, si mise un paio di vecchie scarpe di Ursula e un paio di calze di cotone che le aveva regalato Amaranta Ursula, e fece un fagottello con i due o tre ricambi che le restavano.
“Mi arrendo,” disse a Aureliano. “Questa casa è troppo per le mie povere ossa.”
Aureliano le chiese dove sarebbe andata, e lei fece un gesto vago, come se non avesse la minima idea della sua meta. Cercò di precisare, tuttavia, che sarebbe andata a passare i suoi ultimi anni da una cugina prima che viveva a Riohacha. Non era una spiegazione verosimile. Dalla morte dei suoi genitori, non aveva avuto rapporti con nessuno, nel villaggio, né aveva ricevuto lettere o messaggi, né aveva mai parlato di parenti. Aureliano le diede quattordici pesciolini d’oro, perché lei era disposta ad andarsene con tutto quello che aveva: un peso e venticinque centavos. Dalla finestra della stanza, lui la vide attraversare il patio col suo fagottello di roba, strascicando i piedi e inarcata dagli anni, e la vide infilare la mano in un foro del portone per assicurare il saliscendi dopo essere uscita. Non si seppe più nulla di lei.
Dopo questo paragrafo non viene mai più nominata, e con la sua scomparsa sparisce la casa come entità: ne rimarranno pezzi (una stanza, un pezzo di giardino) ma ne viene meno l’unità, e perde il potere simbolico che ha avuto nel corso del romanzo (luogo di ritrovo, di baldorie, di segreti, di misteri).
Tramite questo dispaccio di Bookbear express sono incappata in una citazione che spiega come la vita sia una collezione di una manciata di routine:
If I consider my life honestly, I see that it is governed by a certain very small number of patterns of events which I take part in over and over again.
Being in bed, having a shower, having breakfast in the kitchen, sitting in my study writing, walking in the garden, cooking and eating our common lunch at my office with my friends, going to the movies, taking my family to eat at a restaurant, going to bed again. There are a few more.
There are surprisingly few of these patterns of events in any one person’s way of life, perhaps no more than a dozen. Look at your own life and you will find the same. It is shocking at first, to see that there are so few patterns of events open to me.
Not that I want more of them. But when I see how very few of them there are, I begin to understand what huge effect these few patterns have on my life, on my capacity to live. If these few patterns are good for me, I can live well. If they are bad for me, I can’t.
Naturalmente mantenere questi patterns in moto è una fatica bestiale, e in questi mesi sono appena riuscita a tenerli in piedi, figuriamoci renderli belli. Ecco quindi l’immagine del genitore, della fornitura “gratuita” di patterns su misura, accoglienti, funzionali. Naturalmente è una gioia immensa, oltre che un grandissimo privilegio, aver ricevuto questa forma di cura nel momento in cui era anagraficamente opportuno, ed è una fonte di orgoglio (e il corso naturale degli eventi che ho avuto la fortuna di vivere) il fatto che la mia autonomia si materializzi nel mettere in piedi le routine che scelgo per me e che condivido con la mia comunità. Tuttavia credo che quest’anno sia emerso a più riprese un senso di stanchezza che mi ha riportato, in maniera quasi istintiva, alla nostalgia di una casa pulita senza che la dovessi pulire io, di un ritmo stabilito per me affinché io potessi fiorirvi dentro. Mi dicono che ci possono mancare anche le cose che è giusto non ci siano più, come sempre mi fido di chi mi osserva con amore e provo ad attraversare questa ed altre “mancanze”.
Tre film e tre madri
In Fish Tank la protagonista, Mia, vive con sua madre e sua sorella e conduce una vita sconquassata in cui l’unica cosa che sembra darle gioia è ballare. Fin dalla prima scena, per farlo si nasconde in una casa sfitta: non c’è nessuno spazio per sentirsi sé stessa sotto il tetto di sua madre. Si trovano molte cose belle in rete sulla regista Andrea Arnold (rimando a questa puntata del podcast Riccetto e a questo numero della newsletter di cinema Singolare, Femminile) e sul film (qui una recensione sul New Yorker) ma quello a cui penso oggi è una scena in cui Mia torna a casa e chiede “Is there any dinner?”. In quello che è uno dei pochissimi dialoghi con la madre, la risposta è: “It's a bit late for that now? What do you think this is, a café?” Nonostante la donna non ha l’aria di una che abitualmente cucini per le figlie (testimoniata dalla totale assenza di sorpresa di fronte a questa risposta) Mia lo chiede comunque, e mi colpisce l’immortalità del desiderio viscerale di vedere i propri bisogni semplicemente soddisfatti, anche agli orari sbagliati.
Linda veut du poulet! è un film animato che dura meno di un’ora e un quarto: la mamma di Linda le fa un torto e per farsi perdonare le promette di esaudire un suo desiderio, e la bambina sceglie il pollo ai peperoni che le faceva il suo papà, che non c’è più. A Parigi, però, c’è la grève générale: i supermercati sono chiusi, e i privati che gestiscono vendite al dettaglio sono impegnati per la manif per cui la piccola Linda sembra destinata a rimanere insoddisfatta. Per qualche ragione, la mamma non sembra potersi arrendere: furti, inseguimenti in macchina, chiamate insistenti alla sorella, tutto pur di mettere in tavola il desiderato piatto. La mamma di Linda, a differenza di quella di Mia, fa davvero il meglio che può, ma quello che Linda desidera (ciò di cui ha bisogno?) sembra essere fuori dalla sua portata. Il pasto che verrà preparato avrà bisogno, per essere portato in tavola, di un villaggio: una rivolta di bambini, un camionista paziente, persino la sorella stressata partecipano alla festa finale.1 Linda sembra capricciosa, e forse lo è, ma non è proprio questo il punto? In quale altro momento della vita sì può sbattere i pugni dicendo “Voglio questo!” e avere decenti probabilità di ottenerlo? Stavo riguardando alcune delle risoluzioni di Alok V. Menon, e fra quelle del 2021 (le trovate qui) leggo: “no one is coming to rescue you. this is not a tragedy, it’s an opportunity. become the person you were waiting for.” Come dicevo prima, l’autonomia è uno sballo. Ma è (per la maggior parte) incompatibile con i capricci. Mi è sembrato bello vedere una rappresentazione così gioiosa e comunitaria di cosa significa accontentare una bambina.
Ci speravo tanto, di poter vedere Vermiglio dopo averne letto così bene per mesi: non sono rimasta delusa. Ho letto proprio ieri una bellissima disamina (via The Culture We Deserve, la newsletter di Jessa Crispin) del film attorno al tema dell’ambivalenza nei confronti dell’idea della maternità. L’articolo analizza in quest’ottica il personaggio di Lucia: nella seconda metà del film, dopo aver dato alla luce suo figlio, semplicemente si dilegua nei boschi (e nel suo malessere) delegandone la cura al resto della famiglia. C’è però anche un’altra madre nel film, la madre di Lucia appunto, che dopo forse una decina di parti, e dopo aver perso un paio di bambini, è comunque di nuovo, e sempre, incinta. Che non ci sia denaro per sfamarli tutti appare chiaro quando lei rimprovera il marito per l’acquisto di un disco (soldi che avrebbero potuto spendere altrimenti), e questa lite rende evidente che è solo la padrona di casa a portare il peso di questi conti. Dopo l’ultimo parto, il figlio maggiore le porta dei fiori e viene rimproverato dal padre perché li ha rubati: la madre, sudata e stanca ma con uno sguardo pieno di rabbia, accusa il marito di prendersela col figlio per sfogare il proprio senso di inadeguatezza (mai, nella decina di parti precedenti, il marito ha pensato di portarle dei fiori). Poco dopo il film ci mostra il capofamiglia sbirciare in una stanza in cui la moglie culla il nuovo nato: forse io ci ho visto un po’ di invidia in quello sguardo, frustrazione per la sua irrisolvibile estraneità all’amore e alla cura di cui è testimone. Il padre-padrone di questa famiglia numerosa dispone dei loro destini, sparge umiliazioni e lodi, ma non si siede a fare i conti della spesa, né è mai mosso dal desiderio di rendere più facile, più bella, più profumata la vita di sua moglie e della prole. A proposito, mi è parso molto chiaro, anche se forse non particolarmente originale, questo intervento di Kate Manne dall’appropriato titolo “When Do Women Get Cared For (by Men)?”. La cura, in Vermiglio come altrove, è materna.
Non sappiamo se la mamma di Lucia avrebbe voglia anche lei di andarsene nel bosco lasciando il pargolo alle cure altrui, e abbiamo solo un piccolo squarcio di come Lucia processerà la sua maternità negli anni a venire, eppure è sempre l’ambivalenza, in forme diverse e mutevoli, a caratterizzare questi legami: il lutto per un bambino stroncato dall’inverno, il dolore misto ad amore dell’aspettarne un altro (l’ennesimo), la traccia di un compagno bugiardo che Lucia forse vede in suo figlio, e il desiderio di regalargli una vita più facile. La madre di Lucia sembra non possa essere altro che questo (madre), Lucia sembra non volerlo essere e la sorella di Lucia (il mio personaggio preferito) decide di non esserlo (ma di accogliere i figli altrui). Ciascuna di queste tre donne sembra voler essere altro, e al contempo voler essere madre.
Un abbraccio,
Ludovica
Per sottrarsi a questi inviti basta cliccare qui. Le vecchie missive spedite dal 2019 al 2023 sono custodite qui. Potete inoltrare questa mail a qualcuno che vi piace.
Devo ammettere che avrei adorato se il film si fosse concluso con un tofu ai peperoni, perché buona parte della trama ruota attorno al fatto che l’unico pollo che la mamma trova è assolutamente vivo, e diciamo che “come tirare il collo a questa creatura?” non è esattamente il mio argomento preferito. Restiamo nella metafora.