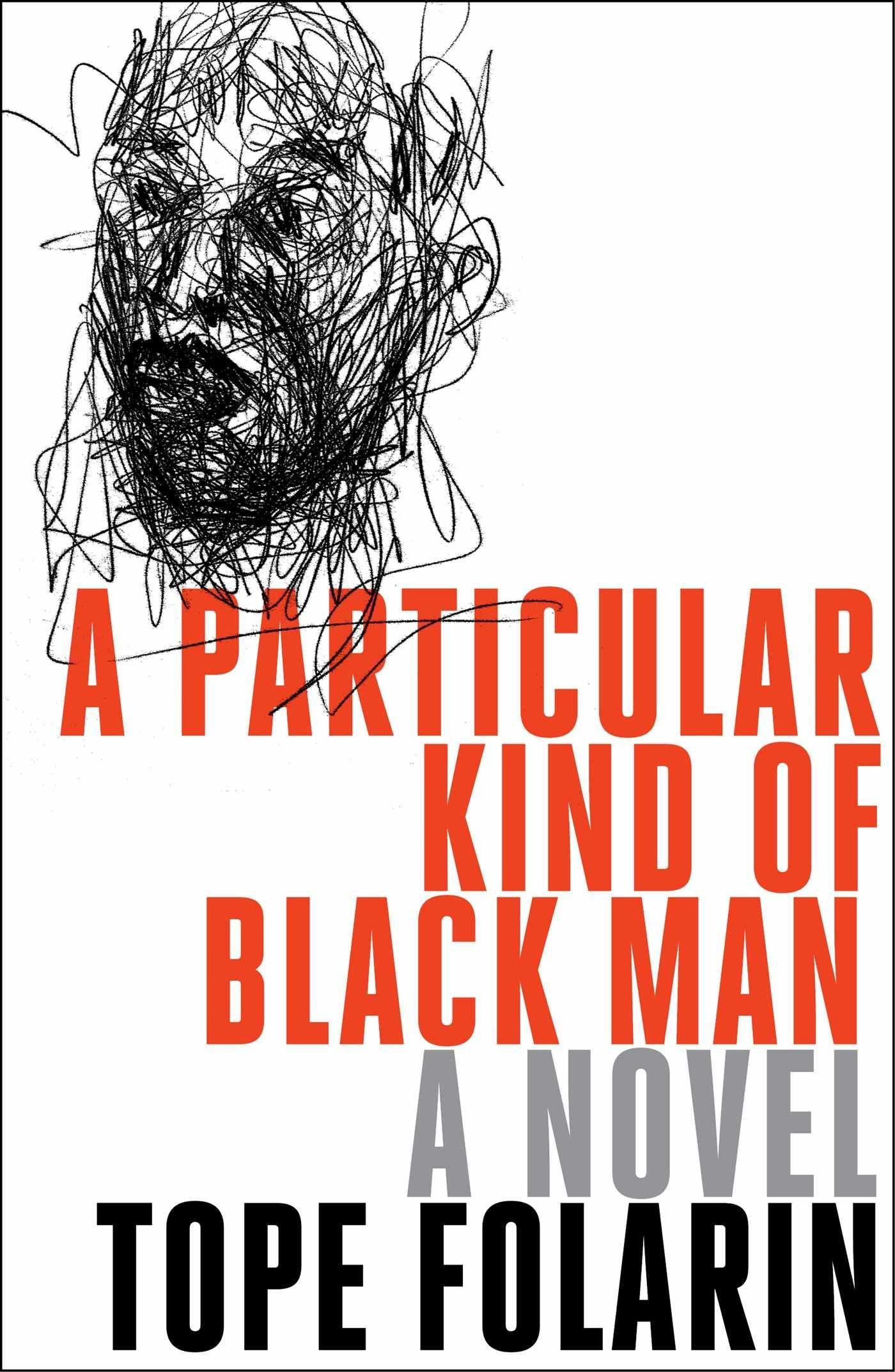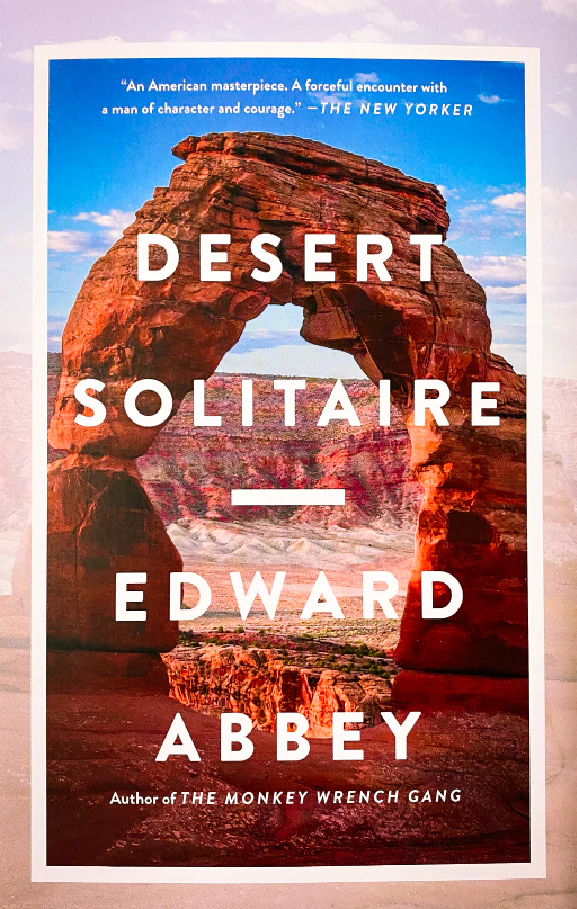Da quando sono tornata dal mio viaggio in Utah ho cercato spesso di destreggiarmi fra vari pensieri che ho voglia di condividere, ma non so se sono ancora riuscita a trovare una quadra. Siccome ci sono tantissime cose che voglio appuntarmi, questa entry è divisa in due parti. Questa prima parte si affida all’elenco, nella speranza che la giustapposizione di appunti contribuisca a rendere l’idea del susseguirsi di pensieri, senza negare una vaga organicità che continuo a sperare esista.
A Salt Lake City (come in tutte le capitali degli Stati americani) c’è uno State Capitol, che è la sede del governo. Appena scesi dalla macchina nel parcheggio abbiamo notato decine di ragazzi e ragazzi vestiti a festa, e mentre salivamo la scalinata i gruppetti (e i fotografi) si sono moltiplicati: abbiamo capito che si trattava di un prom, il ballo di fine anno delle scuole superiori americane. Forse eravamo le uniche persone, fra le decine e decine che affollavano il Capitol, a non essere lì per quello. L’89% degli abitanti dello Utah sono bianchi, e questa demografia si rifletteva nella omogeneità che vedevo: continuavo a ripetere quanto i vestiti, le pose, le scelte estetiche dei ragazzi e delle ragazze che vedevo mi sembrassero “tutte uguali”. Il punto non è solo demografico, naturalmente: anche il mio liceo a Roma aveva pochissimi studenti di ascendenza diversa dalla mia, eppure (almeno nella mia memoria) c’erano tante modalità espressive a cui persone diverse si rifacevano, anche per esprimere “eleganza” in una festa formale. Mi sono chiesta cosa possa voler dire costruire i primi pezzetti della propria identità in un contesto dove sembra esserci così poco spazio per sperimentazioni di diversità.
Naturalmente, la parola chiave della frase precedente è sembra: Legendarium Books è una libreria specializzata in fantasy e sci-fi che funge anche da luogo di ritrovo per la comunità queer di SLC, ed è solo un esempio della complessità della città. Lo Utah è lo stato la cui popolazione è cresciuta di più nell’ultimo decennio, in buona parte a causa di una forte migrazione, soprattutto dalla California. Prezzi delle case più bassi, assieme alla accessibilità della natura sono fra i fattori che rendono la scelta allettante, e con gli immigrati arrivano mondi diversi, che si intravedono anche passando pochi giorni in città.
D’altronde anche il posto all’apparenza più omogeno cela storie inaspettate, come quella (fittizia, ma, sospetto, non del tutto immaginaria), del protagonista di A particular kind of black man, il romanzo di Tope Folarin che ho iniziato sul volo di ritorno dal viaggio. Tunde è nato ad Ogden, una quarantina di minuti a nord di Salt Lake City, da genitori nigeriani che non si stancano di evocare per lui quello che si sono lasciati alla spalle, e che al contempo immaginano davanti a sé una vita da americani. La Nigeria, per Tunde, è soprattutto “un posto dove tutti sono neri”, in netto contrasto con l’impossibilità di trovare attorno a sé, a parte suo padre, qualcuno che possa modellare per lui the kind of black man I wanted to be. Come l’autore del romanzo, Tunde si trasferisce in Texas all’inizio della sua adolescenza, per cui lo Utah è in realtà uno sfondo piuttosto pallido alla sua formazione: un simbolo di quella società Americana nella quale il padre è impaziente di confondersi.
La vera integrazione si rivela però per Tunde ben più complessa di quella assimilazione che suo padre persegue: se l’uomo fa fatica a tenersi un lavoro (e una moglie) perché combatte con forze sistemiche ben più grandi di lui (il razzismo, l’isolamento), il ragazzo inizia a notare che la fonte della forza del padre, cioè che lo rende un aspirante americano, è la capacità di “guardare fisso in avanti, scalciando via il dolore e il mal d’animo”. Questo è quello che a Tunde sembra non riuscire: in una serie di telefonate con la nonna in Nigeria, che non ha mai visto, lei lo invita invece a guardare dentro, invece che avanti.
“So I want you to focus on you. On the things that make you happy and calm. The thing that make your heart beat faster and slower. This is how you will learn who you are, and what you are supposed to do in this life.”
“Yes, ma”.
Non so se ci ho azzeccato, ma a me sembra questo il bisogno che Tunde esprime quando, per esempio, cerca disperatamente un altro ragazzo nero con cui fare amicizia, o una persona adulta nera che sia nata negli Stati Uniti: un modo di sentirsi nigeriano, di onorare cosa dà ritmo al suo cuore, senza però tornare indietro, via dal posto che conosce, il posto in cui il suo carretto di gelati gli ha riempito le tasche e in cui è possibile, se solo capisse come allungare la mano, afferrare mille modi di essere ciò che vuole.
A Tunde inizia a succedere una cosa strana: per alcuni eventi della sua infanzia, che pure ricorda benissimo, risalta alla sua mente una versione alternativa dei fatti, una sorta di storia parallela che Tunde sa non essere accaduta e che tuttavia sembra un ricordo “vero”. Quando confida a sua nonna di essere spaventato da questo fenomeno, e in particolare paralizzato al terrore di non riuscire più a distinguere le due versioni, a riconoscere quella davvero accaduta, lei non sembra affatto preoccupata:
“That’s what memories are for. They are meant to sustain you and refresh you. Always remember that your memories are for today, not yesterday. They change because you change. […] Before you discard them or assume you are sick, why don’t you allow them to speak to you?”
“Because they aren’t real, Grandma.”
“I am beginning to notice you are very fond on that word. Maybe that is the American in you.”
Il romanzo un po’ si perde: non mi pare faccia grande uso di questo espediente narrativo, e mi sono ritrovata un po’ confusa a cercare di tenere assieme i fili della formazione di Tunde, della sua ricerca di sé fra la grande città, Dallas (dove finalmente c’erano “lots and lots of black people” con cui confrontarsi), l’università, e infine un viaggio in Nigeria.
Tuttavia, c’è un punto su cui continuavo a tornare anche dopo aver finito il romanzo. Il padre di Tunde fallisce molte volte eppure continua, come il figlio intuisce, a guardare avanti (per esempio, cambia città molte volte, ognuna aspettandosi che nella nuova destinazione le cose saranno diverse). Questa fiducia nel futuro è forse proprio un tratto americano (se esiste una cosa del genere), certo un elemento che facilita l’assimilazione del padre, e una componente dello spirito che respira quando arriva in Utah. Tunde, al contrario, che in Utah ci è nato, è ossessionato dalla sua storia familiare turbolenta, dai propri ricordi, dalla pretesa di distinguere quelli veri, dalla necessità di identificare quelli importanti su cui costruirsi come uomo, dalla impossibilità di accedere a quelli dei suoi genitori, che pure in qualche modo contribuiscono a formarlo. E la nonna, che non sa nulla del mondo in cui Tunde cresce, e chiama “americane” le parti di lui che non riconosce, sembra invece inguaribilmente concentrata sul presente, che è una sorta di flusso che nulla trattiene e nulla spera, una cosa che si può solo ascoltare con pazienza.
Poco più della metà degli abitanti dello Utah sono membri della Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: la storia di questa denominazione religiosa è intrecciata ad un sacco di aspetti della vita politica e culturale della regione. Per esempio, nella rivelazione che il fondatore Joseph Smith ha trasmesso ai suoi fedeli, si vieta tabacco e alcool, ma anche “hot drinks”, e in virtù di questo precetto la maggior parte dei membri della LDS non beve nemmeno caffè. Questo articolo del New Yorker è una disamina della pratica di bere dirty sodas, cioè bibite gassate “allungate” con creme e sciroppi di vari sapori. Suona bizzarro (e lo è), ma l’articolo secondo me è molto efficace nel dipingere vividamente un rituale, un costume, restituendone anche un’inattesa familiarità.
I arrived at the Swig in Saratoga Springs around 3 P.M., in the middle of the after-school rush. Outside, as a dozen or so cars waited their turn at the window, a small team of cheerful young employees were acting as an advance guard, approaching each vehicle to take orders. Inside, another group pulled and mixed drinks with impressive speed, while singing along loudly to Natasha Bedingfield’s “Unwritten.” Though there was a small counter where, theoretically, a customer could order and pay on two feet, almost no one did, and there was minimal seating. “We’re really fitting into people’s busy days,” Alex Dunn, the company’s C.E.O., told me as we surveyed the scene. “This is not a destination. It’s a treat. It’s a break.”
Invito: quando ti è capitato di passare dall’incredulità a una sorta di comprensione nell’apprendere di un rito altrui?
Da Salt Lake City abbiamo guidato verso Sud, fermandoci a Torrey, e al Capitol Reef National Park, e poi attraversando il Grand Staircase-Escalante National Monument lungo la Highway 12, una delle National Scenic Byways. La nostra destinazione era un motel alle porte del Bryce Canyon, che avremmo visitato il giorno dopo, per poi proseguire verso Zion. So esattamente dire qual è il punto in cui il paesaggio è cambiato: Salt Lake City è un posto molto diverso da New York, la vita di Tunde è molto diversa da quella delle migliaia di immigrati di seconda generazione che presumibilmente hanno condiviso tragitti in metropolitana con me negli ultimi sei anni, eppure tutto sommato la mia esperienza in quei giorni era conoscibile, qualcosa che avevo gli strumenti per capire, leggendo le statistiche demografiche dello Utah, o scambiando due chiacchiere col fratello di Tommaso che vive lì, o leggendo romanzi ambientati a pochi chilometri di distanza. A un certo punto invece, sulla State Route 24 poco dopo Loa, mi sono resa conto che mi stavo avvicinando a un posto il cui mistero non avrei davvero potuto penetrare.
Mentre terra comincia a farsi rossa, e il cielo sconfinato, e i paesini radi e minuscoli, prevale la sensazione di essere in un luogo più che remoto, un luogo che fino a poco tempo fa non era stato nemmeno completamente mappato, un luogo la cui accessibilità grazie alle autostrada è in realtà una completa illusione. Qualche tempo fa ho visto un video in cui un comico diceva che New York è speciale perché in mezzo a così tanta gente non puoi pensare di essere il protagonista: “it is good for the soul to be forcibly ejected from the story you are constantly telling yourself about your own life”. Similmente il deserto dello Utah Sud-Occidentale sembra beffarsi dell’idea che la tua individualità sia rilevante.
Desert Solitaire è un libro del 1968 che raccoglie alcune riflessioni di Edward Abbey, un ranger all’Arches National Park. Io e Tommaso non ci siamo stati (è più ad Est rispetto al nostro itinerario), ma leggere questi saggi al mio ritorno ha aiutato a chiarire alcune delle mie emozioni. Una premessa fondamentale è che la voce narrante è insopportabile: pieno di sé, aggressivo, antisociale. Per esempio, argomenta che le strade nei parchi nazionali sono un abominio (“importanti per il commercio, il traffico, e altre cose di nessun valore”), e che rendere accessibili le meraviglie del territorio americano non ha alcun valore: io naturalmente non so nulla di conservazione ed ecologia, ma sono infinitamente grata della possibilità di non aver dovuto camminare tre giorni per bearmi della magnificenza di cui mi sono beata, e sono abbastanza certa che ci sia del valore (educativo, umano, persino spirituale) nell’esporre la gente al proprio territorio, pur con tutte le complessità che il turismo comporta. Leggendo in giro mi pare di capire che i contributi di Abbey, più che radicali, siano obsoleti e poco utili.
A più riprese Abbey si rapporta al territorio sconfinato che lo circonda come se lui stesso ne fosse il centro, e lo chiama perfino “il paese di Abbey”. Una mattina all’alba si sente preso da “un ridicolo desiderio di possesso”, e dopo aver interrogato la “sanità” di questo desiderio conclude che la domanda non è così importante visto che non c’è nessun altro essere umano a contendergli questo possesso. La mia prima impressione, come accennavo prima, è stata diametralmente opposta: non solo il posto in cui sono non è “mio”, ma non potrebbe esserlo in nessun senso, nemmeno se fosse in vendita e lo comprassi, nemmeno nei momenti in cui non c’erano altri turisti accanto a noi, nemmeno se fossi la sola ad averlo mai visto nella storia. Non è mio perché opera al di fuori del tempo umano, rifiuta l’umano in quanto in larga parte inospitale, e non può essere né compreso con lo sguardo, né contenuto in una descrizione o una foto. Per questo dicevo prima che l’accessibilità è una illusione: io e Tommaso, due hikers entusiasti ma di certo non esperti o particolarmente avventurosi, abbiamo potuto godere di sentieri ben segnalati, o cercare con la macchina uno spazio speciale per goderci il tramonto, e con qualche anno di esperienza in più potremo in futuro raggiungere ulteriori angoli, più ardui e nascosti, ma in qualunque caso potremo solo sfiorare questa natura così misteriosa. Forse i geologi che studiano l’erosione e la formazione paziente dei canyon, o i biologi che catalogano piante misteriose, o gli astronomi che approfittano delle notti più buie del paese per guardare le stelle avranno una sensazione diversa dalla mia, e ho provato un po’ a leggere qualcosa di divulgativo che mi aiutasse a farmi un’idea più precisa delle forze naturali che hanno reso questo pezzo di mondo improvvisamente così diverso da quello che ho sempre visto. Però, come scrive Abbey, questi sono luoghi in cui si vive “una sospensione del tempo, un presente ininterrotto” e questa totale cancellazione della linearità, dell’idea di poter andare da qui a lì, mi sembra una sensazione incompatibile col possesso, con la comprensione, con l’accesso.A differenza di altri ecosistemi, di altre meraviglie della natura che pullulano di vita, nel deserto, di base, non c’è niente. Per dirla un po’ meglio, con le parole di Abbey:
… le forme di vita non si affollano su altre forme di vita come succede in altri posti, ma sono sparse per tutto il territorio con parsimonia e semplicità, con tanto spazio a disposizione per ogni cespuglio e albero, per ciascun filo d’erba…
Ecco quindi che così come il tempo, anche lo spazio mi sembra sfuggire alla mia comprensione; non posso che sottolineare, banalmente, come sia tutto incredibilmente, sorprendentemente e miracolosamente grande.
Nonostante la sua spocchia, Abbey ammette ogni tanto la sua limitatezza di fronte al posto in cui si trova:
Sorveglio quest’albero da quando sono arrivato nel parco, nella speranza di imparare qualcosa da esso, di scoprire il significato della sua forma, di fare dei collegamenti, attraverso la sua esistenza, con ciò che c’è dietro. Non ci sono riuscito. L’essenza del ginepro continua a sfuggirmi a meno che, come adesso sospetto, la sua superficie non sia anche la sua essenza.
Ci sarebbe molto altro da dire su questo libro, che racconta storie di cowboy e nativi, di estrazioni minerarie, e di tempeste repentine, eppure mi fermo qui, sull’idea che si possono guardare i canyon e sentire qualcosa di divino, oppure anche non sentire niente che vada oltre la meraviglia, perché mai è stato così facile accettare che una cosa bella non debba necessariamente insegnarci qualcosa, o trascendere la sua bellezza; quando la bellezza è così tanta è davvero sufficiente, ed è davvero anche essenza.
Il tema della conservazione, che Abbey tocca con vena puramente polemica, è ovviamente di centrale importanza in queste zone. Questo articolo del New Yorker ne racconta un pezzetto, a partire dalla storia di due chef che operano un ristorante a Boulder, un paesino nel cuore del Grand Staircase-Escalante National Monument, sulla Highway 12. La storia delle due donne e del loro progetto imprenditoriale e culinario è incredibilmente affascinante (e che smacco non aver letto l’articolo prima del viaggio, così da accertarmi di mangiare al loro Hell’s Backbone Grill), ma il motivo per cui cito questo articolo è la battaglia politica in cui le due donne si sono attivate, per proteggere i confini del Monumento in cui vivono. Il Grand Staircase-Escalante National Monument è un ottimo esempio della sensazione di incomprensibilità che provavo a descrivere prima: è una gigantesca area, non una singola formazione geologica (come invece sono per esempio gli archi del parco in cui lavorava Abbey, o i canyon compresi nel parco nazionale di Zion), ma piuttosto una serie di picchi e altopiani, l’ultima area degli Stati Uniti contigui ad essere mappata.
Although Native Americans lived in what would become Grand Staircase for twelve thousand years, early European-Americans avoided the area assiduously; so daunting was its terrain that, for centuries, it deflected the otherwise unstoppable force of Manifest Destiny. As late as 1868, a U.S. War Department map of the western United States contained an enormous blank spot where the monument would one day be. In 1871, when the explorers of the second Powell expedition arrived at the edge of that blank spot, their leader looked out on the “multitude of chasms before us,” and declared that “no animal without wings” could cross it. When they crossed it anyway, they encountered both the last river and the last mountains in the Lower Forty-eight to be named and mapped.
Clinton, nel 1996, designò l’area come National Monument per proteggerne la ricchezza ecologica, geologica e paleontologica, e nel suo primo governo Trump ha decretato una significativa riduzione dell’area protetta (ora ripristinata da Biden ai suoi confini originali). Oltre alla battaglia legale (questo tipo di decisioni spetta al Presidente o al Congresso?), l’articolo ripercorre le motivazioni di chi, fra la popolazione locale, supportava o meno questa decisione. Da un lato, nella zona serpeggia una certa avversione all’idea del controllo federale:
That sentiment is common throughout the West, where it is the most notable regional instantiation of the grand American tradition of disliking the federal government. […] But there is a reason that Trump cut monuments only in Utah. Among other Western politicians, shifting economies and demographics have begun to change attitudes toward public lands, but Utah’s governing class remains intensely hostile to federal authority. That hostility stems in part from a long history of conflict between the U.S. government and the Mormon Church.
D’altro canto però l’introduzione della protezione federale ha avuto diversi effetti positivi nella zona, riducendo la disoccupazione, e non solo nell’indotto legato al turismo. I nuovi confini del Monumento che Trump aveva creato, si erano poi rivelati appositamente adattati a massimizzare l’accesso ai giacimenti di carbone, rame, cobalto, uranio e altre risorse naturali di cui la zona abbonda. L’industria estrattiva (proibita nelle aree protette dalla designazione di Monumento) avrebbe quindi largamente beneficiato della novità. L’articolo sottolinea anche che parte del supporto al progetto era figlio di una grave misinformazione: gli allevatori non possono accedere all’area del Monumento, ma l’articolo argomenta che la crisi dei ranch ha più a che fare con la crescita dell’agricoltura industriale e altri fattori macroeconomici, che con l’esistenza della protezione federale. Ecco quindi che una vicenda tutto sommato “piccola” racchiude tanti pezzi importanti della società americana, recente e vecchia di secoli: la sfiducia di alcuni Stati nei confronti del governo federale, l’importanza della terra e i conflitti sull’accesso, la creatività di progetti ambiziosi e la frustrazione di restare indietro.
A presto, con un altro elenco di pensieri da Zion e Las Vegas. Un abbraccio,
Ludovica
Per sottrarsi a questi inviti basta cliccare qui. Le vecchie missive spedite dal 2019 al 2023 sono custodite qui. Quelle dal 2024 ad oggi sono qui. Potete inoltrare questa mail a qualcuno che vi piace.