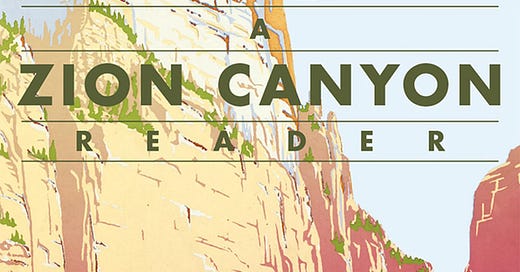Dove ero rimasta?
I saggi che compongono A Zion Canyon reader sono molto diversi fra loro: c’è un testo che sembra tratto da un libro di scienze del liceo in cui un geologo distingue i diversi modi in cui l’acqua scorre e si raccoglie nel canyon; c’è un diario di viaggio di un certo George Fraser che nel 1914, insieme al figlio, ha visitato la zona; c’è una descrizione lisergica del sentiero Angels Landing ad opera di un certo Lyman Hafen, sobrissimo, ma assetato e accaldato al punto da avere allucinazioni.
Sfogliandolo abbiamo imparato che il nome Zion è stato scelto dai primi residenti Mormoni della zona: significa “paradiso”, ma il riferimento non è tanto alla bellezza della natura, quanto al senso di sicurezza che il luogo, così remoto, dava al gruppo, in fuga dalle ostilità che subivano in quel periodo. (Secondo John Wesley Powell, un geologo americano che è stato il primo ad aver esplorato il Grand Canyon e diverse zone del Sud-ovest, i nativi chiamavano il canyon Mukuntuweap, ma gli storici non sono unanimi sulla autenticità di questa designazione). I primi coloni di quella che oggi si chiama Springdale, il paesino all’inizio del canyon, avevano trovato la loro zona franca:
The story is told that during a visit by Brigham Young in 1870, the underwhelmed Mormon prophet, irritable either from the bumpy ride into Zion Canyon or from finding among residents an open violation of the faith’s proscription against tobacco, dismissed the canyon, saying, “This is not Zion,” and perhaps adding, “Zion is the pure in heart.” And the legend says that the settlers dutifully (or impudently) began referring to the canyon as “not Zion.”
Più di quattro milioni e mezzo di visitatori sono stati a Zion nel 2023, ed è difficile ritrovare il senso di smarrimento spaventato che alcuni dei racconti di viaggio di questa raccolta trasmettono:
Today instead of being the land that God forgot, it is the land that man remembers and tells his friends about, reinforcing his telling with pictures of unbelievable quality. It is a land to return to again and again, for no one can ever wholly see it, so responsive and sensitive is it to the hours and the seasons.
Evidentemente non è facile trovare il compromesso fra accessibilità e conservazione, due istanze che il sistema dei National Parks ha a cuore, e forse questo è stato il momento del viaggio in cui più mi sono sentita parte di una massa “violenta”, fuori luogo rispetto a quello che stavamo attraversando. Nella scorsa newsletter citavo Abbey con il suo Desert Solitaire: avrebbe odiato a morte la navetta che percorre il canyon, o il parcheggio strapieno sul retro del Visitors Center. Eppure, nei momenti di quiete che abbiamo avuto la fortuna di vivere nei due giorni e mezzo che abbiamo passato nel parco (per esempio, seduti su una roccia nella Checkerboard Mesa, esausti dopo aver camminato nel torrente in un passaggio bellissimo che si chiama The Narrows; o soli al tramonto lungo il Pa’rus trail), il silenzio era così profondo, la luce così trasparente, che la parola “eternity”, che torna di continuo nello Zion Canyon Reader, mi sembrava non solo appropriata, ma confortante.
Fra Zion e Las Vegas ci sono 150 miglia di deserto. La transizione non è semplicemente netta, direi piuttosto brutale giacché la città si staglia, incongrua e sgraziata, semplicemente nel mezzo del nulla. Dopo il confine col Nevada abbiamo letto su internet la storia della città: siccome in quella zona c’è dell’acqua, negli anni ’30 il governo federale ha costruito una diga, la Hoover Dam. Circa 20,000 uomini dalle provenienze più disparate affollarono la zona per approfittare della opportunità di impiego associata al cantiere. Per intrattenere questa marea di giovani, con della paga in tasca e senza famiglie al seguito, hanno aperto in quegli anni i primi casino. In un certo senso quindi è un posto “finto” per definizione, e la città come la conosciamo parte tutta da qualcuno che si è accorto di un mercato potenziale e aveva i mezzi per soddisfare una domanda inespressa.
L’86% dello stato è inabitato, come scopro leggendo questa recensione di un libro che raccoglie storie di abitanti del Nevada rurale (un prete cattolico che dice messa nei casinò, una gara a chi caccia più coyotes): nonostante Las Vegas sia una città grande e assordante, sta in un mezzo a un posto dove semplicemente non c’è abbastanza gente, e forse questa solitudine è importante tanto quanto il traffico dello strip per capire questo posto. Quegli operai della diga, esausti e accaldati, non credo si sarebbero mai immaginati che la città che a stento trovava posto per loro, con i suoi circa 5,000 abitanti nel 1930, sarebbe diventata la Mecca dell’intrattenimento americano, e una sorta di epitome di come l’America ce la immaginiamo, la viviamo, e la proiettiamo (non so bene se nessuna di queste cose si avvicini a quello che l’America è).
Abbiamo perso in fretta i soldi che avevo messo in conto di poter giocare, e siamo andati un po’ in giro al di fuori del famoso strip, dove sorgono gli alberghi e i casino. A Las Vegas, per esempio, c’è una grandissima Chinatown, dove abbiamo mangiato dei soup dumplings eccezionali in un ristorante Shanghainese. C’è anche un quartiere commerciale piuttosto carino con caffè, librerie, e negozi di antiquariato che vendono cimeli degli alberghi storici. Il fatto che ci sia una parte “normale” della città, che gravita attorno agli alberghi, ai casinò, e agli show, ma non ne fa direttamente parte, è quasi una dissonanza cognitiva. In fila alla cassa in un negozio ho origliato due ragazze parlare del costo dell’affitto, in crescita come in tante altre città americane. Non so se la parola “turistificazione” ha senso in un posto che è nato come un punto di intrattenimento, eppure mi è sembrato che la città avesse una sua personalità, una sua natura separata da quella luccicante e assurda dello strip. E lo stesso strip, innegabilmente cacofonico, volgare, brutto, sembra comunque racchiudere una sorta di fascino difficile a descriversi.
E in effetti a descriverlo ci hanno pensato due celebri architetti, Denise Scott Brown e Robert Venturi, il cui lavoro è raccontato in questo fantastico episodio del podcast 99% Invisible. Scott Brown, all’inizio della sua carriera, fa un viaggio a Las Vegas:
Upon her arrival, she felt a cold shiver. “Is this love or is this hate?” she recalls asking herself. She wasn’t sure, but she did know she needed to photograph it before it disappeared.
Negli anni successivi continuerà a studiare quella sua iniziale reazione di repulsione e attrazione, oltre a prendere sul serio l’evidente fascino che la città esercitava sul pubblico americano: già negli anni ’60 il flusso di turisti era tale da non lasciare dubbi sul fatto che Las Vegas piacesse, e tanto. Un indizio del perché lo troviamo nelle leggi cittadine: tecnicamente lo strip è al di fuori dei confini della città, e quindi non è sottoposto alle zoning laws e al resto dei vincoli urbanistici di Las Vegas, il che consente ai costruttori di buttare giù i palazzi non appena non corrispondono più al gusto del momento, creando un panorama che si adatta di continuo e sembra sempre in qualche modo “nuovo”.
This legal flexibility allows the strip to change and build new structures almost every decade. Old casinos are imploded to make way for newer, more profitable ones, perpetually redesigned to attract new tourists with each new iteration. The Strip is designed and redesigned, over and over again, for its visitors.
Las Vegas, quindi, piace perché le cose che non funzionano più, semplicemente, le buttano giù, e rimangono quindi solo elementi che possono garantire introiti, flussi, hype. Ma c’è anche un altro elemento della città che i due architetti studiano nei loro viaggi: nonostante il caos, i neon e il rumore, le folle in vacanza sembrano trovare sempre il loro posto, in una sorta di ordine funzionale complessivo. Nel loro libro “Learning from Las Vegas” approfondiscono l’idea che un palazzo debba indicare la propria funzione, essere intellegibile: le insegne luminose e le frecce giganti non lasciano nessuno spazio all’interpretazione, bensì indirizzano e chiariscono. Questo articolo del New Yorker, che ricostruisce l’eredità del testo a cinquant’anni dalla sua pubblicazione, pone lo shock culturale che due intellettuali della costa Est possono aver provato come complementare, e non antitetico, all’attenzione che i due hanno dedicato alla città. Anche se ci sembra brutta, Las Vegas piace, e funziona, e questo la rende in qualche modo interessante per definizione:
What struck me when I went back to reread the book is how deliberately it works to collapse the distance, and therefore the distinction, between enthusiasm and skepticism, and ultimately between documentation and critique. Above all, “Learning from Las Vegas” argues for a curious and open-minded anti-utopianism, for understanding cities as they are rather than how planners wish they might be—and then using that knowledge, systematically and patiently won, as the basis for new architecture. “We rode around from casino to casino, dazed by the desert sun and dazzled by the signs, both loving and hating what we saw,” she recalled. “We were jolted clear out of our aesthetic skins.”
Las Vegas ti ricorda in continuazione dove sei, anche perché è impossibile giocare d’azzardo se si ha una buona memoria. In questo racconto la scrittrice Shannon Pufhal racconta delle sue visite a Las Vegas da bambina e adolescente, quando sua mamma e sua nonna la lasciavano scorrazzare per la città mentre giocavano, o la facevano sedere alle slot machines con loro (ben prima che la sua età glielo consentisse). I suoi ricordi sono l’occasione per riflettere sul gesto ipnotico di quella posizione, su quanto poco c’entri la “fortuna”, intesa come profonda inabilità di conosce l’esito di un’azione prima che la si compia1, e su come, nonostante questo, l’illusione della fortuna preserva l’illusione della libertà.
The sense that a game of chance asks or answers a private, wordless question, and that luck reveals our moral worth, is central to the magic of many modern things
For most of us, gamblers or smartphone users, luck is about the ability to risk ourselves in the void and yet sustain minimal loss. Which, it hardly needs saying, is neither luck nor risk. Las Vegas, like so many other places and things in the twenty-first century, has turned luck to brief anodyne. It was Max Weber, writing a century ago, who proposed we’d vanquished God and the divine and thus made “calculable and predictable what in an earlier age had seemed governed by chance.”
Poiché il caso è lo stesso ad ogni mano, il gioco d’azzardo ci solleva dalla responsabilità di guardarci intorno, o indietro, e per una ragazza che sta costruendo la propria identità, con pochi ricordi e ancora meno progetti, l’eterno presente scintillante è tutto quello che le serve.
Al ritorno dal mio viaggio, ho iniziato a pensare che ci sia qualcosa di davvero “americano” in questo senso di eterno presente. In questa puntata del podcast The Gray Area ho sentito per la prima volta una citazione di Gore Vidal che recita: “We are forever the United States of amnesia. We learn nothing because we remember nothing”. Il contesto della puntata non potrebbe essere più diverso dalle mie riflessioni su Las Vegas, eppure mentre la giornalista intervistata spiegava le sue idee sulle istituzioni americane ha detto una cosa che inubbiamente fa un po’ pensare al gioco d’azzardo:
that ability to simply replace what needs to get thrown in the garbage means that I feel like there's gonna be something new in 20 years whether we can see it now or not.
Non so se è vero, che per avere fiducia nel futuro bisogna per forza un po’ dimenticarsi il passato. Certo è che per mettere di nuovo una moneta (virtuale) nella slot machine non si può passare troppo tempo a contare quelle che ci si è già infilate, e non è forse il motto stesso della città un invito ad isolare il tempo passato lì, prevenendo che entri nella memoria futura? Se “What happens in Vegas stays in Vegas”, allora forse non sappiamo inferire da quello che succede ora cosa ci aspetta, e quindi non è poi così importante ricordare e assimilare il passato. Torno a pensare allora a Tunde, e alla sua forma magica di amnesia che sovrappone ai suoi ricordi delle storie inventate (ne raccontavo qui): è incapace di riportare alla mente cosa gli è accaduto, e conciliare la sua natura di cittadino americano con la sua (più sfuggente) identità nigeriana implica lasciare andare l’idea che il passato sia qualcosa da preservare, cristallizzato.
Dal tono della frase di Vidal sembra evidente che lui consideri questo un limite, e indubbiamente lo è, ma devo ammettere che c’è qualcosa di affascinante nella capacità di lasciare andare: un senso di libertà e di possibilità che forse sono quello che ci affascina di un viaggio nel deserto.
Un abbraccio,
Ludovica
Per sottrarsi a questi inviti basta cliccare qui. Le vecchie missive spedite dal 2019 al 2023 sono custodite qui. Quelle dal 2024 ad oggi sono qui. Potete inoltrare questa mail a qualcuno che vi piace.
Per i più pazienti, segnalo un meraviglioso ma complesso articolo dell’economista Rachel Meager che riflette su come persino il lancio di una moneta sia un evento deterministico (la meccanica classica può dirci se uscirà testa o croce nel momento in cui lanciamo), e cita il filosofo Charles Pierce che nel 1891 proclama “The chance lies in the diversity of the throws”,